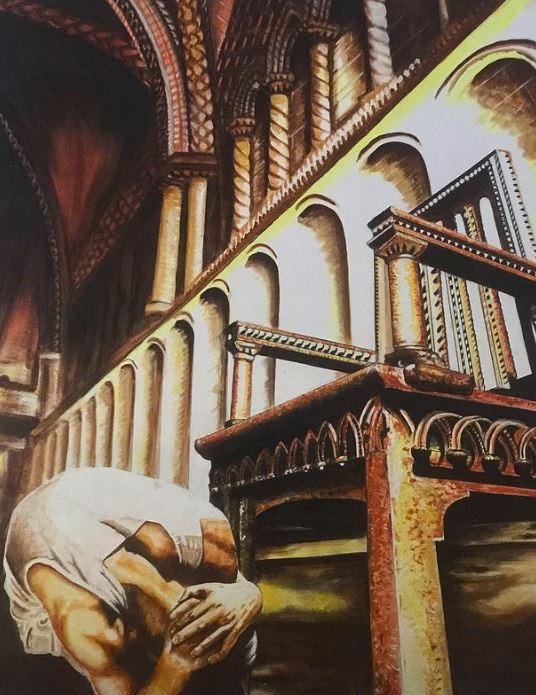
Tentai spesso di rintracciarla, ma poi finii per rinunciarvi. Flora era inafferrabile esattamente come le cose che passavano sopra di me, a bordo di tappeti volanti. Non era colpa sua. Faceva parte della sua natura. Non poteva non essere infedele, non seguire il suo istinto di cutrettola che la conduceva a trillare ora qua ora là, e a saltare continuamente da una siepe all’altra. Eppure nell’intimo si riteneva fedele, forse perché quando si dava a qualcuno lo faceva senza riserve, con slancio totale, e perché ogni volta credeva che il rapporto sarebbe durato per sempre. «Giuliano, tienimi stretta, non lasciarmi più andar via. Picchiami, se vuoi, spranga la porta, chiudila a chiave. Vuoi che stia sempre a casa? Vuoi che mi metta a cucinare? Ti giuro che lo farò, solo che tu lo voglia. Giuliano, tu sei il più caro di tutti. Sei diverso, sei unico…» Ma poi tornava da me sempre più di raro. Le sue orbite erano sempre più larghe e più lontane. Sentivo che c’era in lei un vuoto che nulla avrebbe potuto colmare completamente, una voragine senza fondo, e in ogni momento, anche quando si metteva il bistro sotto gli occhi, o si avvolgeva il boa attorno al collo, dava l’impressione di una nebulosa e nervosa incompiutezza… Così feci uno sforzo tremendo, e fuggii. Significava, lo sapevo, strappare una parte della mia giovinezza, un tessuto di sogni, di fantasticherie e di accensioni esaltanti, perché ero stato un tranquillo visionario, e in certo modo continuavo a esserlo ancora. Ma era meglio che la lasciassi io, prima che le sue folli giravolte la portassero tanto lontano da me da sfuggire per sempre alla mia attrazione. Potevo trattenerla, conservarla totalmente soltanto nella memoria. Poteva essere veramente mia soltanto fissando nelle forme immobili della mente la sua figura mutevole e sempre in fuga. Stavolta la convinzione che per impadronirsi veramente delle cose bisogna perderle non nacque da una fuggevole esperienza, ma da una ferita profonda e sanguinante dello spirito.
DUE PAROLE
Dice Sgorlon di vedere o percepire il mondo come un posto magico dove qualsiasi cosa può accadere. Che i suoi libri sono fiabeschi e stregati. In questo testo, quasi scolastico per timbro e stesura, il protagonista Giuliano, un ragazzino di un immaginario paese Friulano di inizio 900, cresce e porta con sé il lettore nel suo percorso formativo. Un percorso che, sebbene volga al mondo circostante le proprie attenzioni, finisce per svilupparsi in un angusto spazio. La pochezza dei luoghi e dei personaggi è in evidente disarmonia con la facoltà e la potenza narrativa. Un libro che vuol essere un elogio alla lettura e al racconto (orale e scritto) dove, e cito, “i morti sono ombre archetipe così come molti viventi, per converso, sono tanto quieti e trasparenti che non sembrano incarnare la vita.” Quello che, a mio avviso, risulta il fulcro del romanzo è la formazione dello scrittore e il percorso di crescita capacitiva sensoriale e narrativa del romanziere. Non è un romanzo di formazione in senso stretto, come ne abbiamo letti a milioni, ma sviluppa il tema della crescita (lenta e naturale) delle capacità letterarie – meglio dire narrative – dell’autore o di qualsiasi potenziale autore. Come il vecchio Pietro, l’uomo si realizza quando diventa capace di trasformare il visto, il vissuto, in racconto e narrazione.